Di fabio rocco oliva
Il vantaggio di queste città è uno: quando non sai dove andare c’è sempre il mare a toglierti dall’indecisione.
Le onde del mare mi hanno consumato. Non ho sentito più l’odore del sale e non mi sono mai immaginato sugli scogli di fronte ad un mare in tempesta col cielo grigio. Mi sono voltato verso l’asfalto e ho temuto che lì sarei morto. Anita, non ho potuto amarti e non sono durate a lungo le mie riflessioni su quella panchina. Sono stato bene ma non ho potuto amarti.
Correrà, lei correrà sul lungomare con le orecchie ovattate, i piedi bollenti e il vento sul petto, si lascerà il Vesuvio alle spalle, come al solito, scanserà gli ostacoli e si rallenterà e si continuerà a trascinare asmando e non potrà afferrare nulla e non si sentirà altro che un frammento mentre correrà, lei correrà e quasi sorriderà d’un sorriso senza senso come un movimento involontario dei muscoli.
Mi sono ciondolato verso quella panchina. Il mare di fronte come punto di riferimento. Mi è venuto da ridere. Mi è venuto da non provare nulla. Ho sentito picchiettarmi nella testa una strana angoscia non solo mia ma della città in cui vivo. I piccoli miracoli non hanno coperto il marcio d’inettitudine. Non mi sono lanciato nel mare, è vero. Non ha più il senso d’un tempo il mare. Mi sono rallegrato di quello che ho potuto impormi sapendolo solo mio e impossibilitato a comunicarsi ad altro. Mi sento frammentato Anita. Sto bene, sto male, non m’interessa più. Sto in entrambi i modi senza cognizione di logica.
I giornali svolazzano come anatre sul lungomare e inceppano le panchine come stessero ballando un tango, voltandosi con eleganza e indifferenza. Una strana freddezza s’impossessa dei giornali come dei passanti sul lungomare. Il sole rende tutto più giallo e l’afa tutto inafferrabile. Manca spesso la quantità d’aria necessaria per una buona respirazione.
Lei si volta per accendersi una sigaretta, e resta di spalle finché lui non la prende per un braccio e la tira a sé. Lei non sembra essere meravigliata dalla virilità sua e resta un pezzo di ghiaccio. La bacia e armeggia con le mani sul vestito corto. Alla fine del bacio lui è soddisfatto, sorride e cerca uno sguardo d’intesa. Lei non si muove. Guarda per un attimo a terra. Lui pensa d’averla sconvolta. Lei rialza gli occhi e comincia a parlare d’altro come se non fosse accaduto nulla.
Il traffico delle automobili ai semafori mi fa dimenticare che più in là c’è il mare, più in là le isole e più in là il Vesuvio. Mi sembra stia fumando.
Ho corso in gran fretta oltre la villa comunale, l’ho superata scavalcando le aiuole, col pensiero fisso sul da farsi. Si è fermato per una sigaretta su una panchina verde. Poi si è alzato e ha attraversato la strada senza preoccuparsi delle macchine. Poi sono giunto a pochi passi dagli scogli: il Castel dell’Ovo, le coppiette, i corridori e i venditori di taralli. Si è intravisto in mezzo al mare. Mi sono commosso. Ha guardato ancora intorno a sé. Il mare è stato sicuramente più profondo, Anita. Le colline ad est. I greci d’un tempo. Ha sorriso indignato. E’ tutto frammentato e inconciliabile. Non mi sono mai emozionato o sconvolto per alcuna cosa. Ha scavato nella tasca della giacca. Ha preso un pacchetto avvolto in vari strati di fazzoletti. Lo ho guardato un ultima volta, si è guardato intorno e l’ho gettato a mare. Si è voltato. Passo veloce. La testa affondata nelle spalle. La rotonda Diaz.
Le ruote delle macchine maciullano l’asfalto. Un cane tenta d’attraversare la strada.. Gli alberi della villa comunale non odorano.
Veronica come al solito il pomeriggio è affacciata al balcone e suda ed è obesa. Pensa di smaltire tutto il grasso che ha in corpo standosene lì a balcone con due tute invernali addosso. Ma emana solo puzza Veronica, ha peli superflui ovunque. Veronica fuma e beve tè e guarda oltre il suo balcone cosa succede nella villa comunale. Ha il mare di fronte e non sa cosa chiedergli. Veronica ascolta a tutto volume canzoni neomelodiche e lo studente fuorisede che abita a fianco s’infuria perché non può dirle. E’ figlia di un camorrista. E il professore che abita al piano di sotto teme che il balcone non regga. Ma Veronica è determinata e suda, beve tè e ascolta cantanti neomelodici a tutto volume.
- Ho sentito che Anita ha abortito alla fine. Ha deciso di non tenerlo.
- Come poteva tenerlo? Lui non è in grado.
- Poi lei ha preso l’ecografia con la foto del feto e se l’è tenuta. Me l’ha mostrata l’altro giorno. Ha detto che l’avrebbe portata sempre con sé.
- Lui mi ha detto che lei gli ha dato la foto del feto e una cicca di sigaretta.
- Ah sì, e lui mi ha detto che non li avrebbe conservati a lungo. Mi ha detto che il feto era lungo quanto una cicca di sigaretta.
- Così penso avrà fatto un pacchetto e avrà gettato tutto a mare.
Non ci sarà posto per sedersi sulle panchine del punto snai per le bollette di calcio. Fa caldo e sono fuori a ragionare sulle partite e a parlare con qualcuno. Consigli. La domenica mattina sono sempre stanco e rallentato. Tra me e il giocatore, tra le nostre parole e le partite passa una carovana: una famiglia venuta a scommettere. Il padre urla al figlio ritardato che lo precede, un’altro figlio cammina dietro indifferente, il mio vicino continua a parlarmi delle partite, mio padre è dentro in fila per puntare. Ho invidiato il ragazzo ritardato. Ho pensato che nessuno lo invidia. Ho pensato ad Anita e all’aborto. Poi ho ascoltato ancora i pronostici del giocatore che avevo a fianco, poi ho visto avvicinarsi mio padre, poi ho perso la bolletta per due partite che sembravano sicure.
Anita si affaccerà al balcone di casa sua e si guarderà intorno non provando nulla e vedrà il bambino della casa di fronte giocare con i fratelli poi i fratelli del bambino scompariranno e lui si troverà solo e smarrito per un attimo poi seguirà il polline nell’aria e riderà con le braccia verso l’alto per afferrarlo ma non lo prenderà mai dimenticandosi dei fratelli e penserà solo a prendere il polline mentre Anita affacciata al balcone lancerà giù la cicca di sigaretta e la vedrà scivolare verso l’asfalto ma prima dell’urto volterà le spalle ed entrerà in casa e telefonerà per sfogarsi dell’aborto a qualche vecchio amico che l’ascolterà sperando in un appuntamento galante per la sera stessa.
Principio di romanzo appuntato sulla panchina verde della villa comunale di fronte al mare. Prese con sé un cofanetto cinese e infilò dentro una lettera piegata più volte e scritta a mano. Chiuse la porta e si incamminò verso la stazione dei treni. Al passaggio a livello chiuso aspettò qualche minuto che le sbarre si alzassero. Per il prossimo treno bisognava aspettare mezz’ora. Si avviò verso destra costeggiando i binari del treno. Si sedette, poi, nel mezzo dei binari e fumò una sigaretta. Vide la luce della locomotiva. “Cara Matilde quando troverai la lettera sarò morto. Ho messo dei soldi da parte. Usali come vuoi, per i figli”.
Ieri ero ubriaco e mi sono addormentato su questa panchina. Ho abbozzato un romanzo su Anita. Prima di addormentarmi. Ho sognato. Sono vestito di nero, elegante e consumato. Riesco a vedermi da fuori. Sono in una camera grigio-azzurra. Ci sono altri uomini vestiti come me. Li conosco. Sarà il settecento, metà settecento. Di fianco c’è una finestra rettangolare. Tutta la camera è buio. La finestra ritaglia una luce giallo-fluorescente. Attesa. Silenzio. Ognuno pensa la stessa cosa dell’altro. Il nostro fallimento politico. Stiamo per perdere la città. La vedo oltre la finestra. E’ primavera, una bella giornata di primavera. Si distinguono nitidamente il sole e i tetti delle case. Ogni tanto qualcuno parla e siamo in attesa. Prima o poi qualcuno salirà le scale. La porta. La confermare del nostro fallimento. L’aria è immobile e ovattata. Un vecchio appartamento aristocratico del centro storico di Napoli. Da un ombra viene avanti una donna. Ha la pelle chiara e i capelli biondi sono corti. Ha una maglia nera. Una gonna corta grigia e calze nere. I suoi abiti non sono del settecento. Nessuno s’interessa di questo. Si fa avanti. Accarezza tutti noi a turno. Ha un non so che di lascivo. E’ l’espressione allucinata di tutti noi che aspettiamo la fine. Ha il volto devastato. E’ orribile. E’ arrabbiata perché stiamo per perdere la città che abbiamo governato finora. Per le scale stanno salendo. Non li vedo ma sento chiaramente i loro passi e posso immaginarne i volti. I piedi sugli scalini. Le mani sul muro. I cappelli. Giallo scuro. Torce. La donna si mette fra me e la finestra. Mi da le spalle. Gli altri sono seduti sui divani. Non mi guardano. Nemmeno io li guardo. Qualcuno sale le scale. E’ sempre più vicino. Metto una mano sul collo della donna per inclinarne la schiena. Lei mette le mani sul davanzale. I fucili sono in legno. I suoi seni s’afflosciano sul davanzale. I pugnali nelle mani. Ha la pelle rugosa e raggrinzita. Voglio vedere la città. Le sollevo la gonna. I gabbiani. Mi abbasso i pantaloni. Mi appoggio alle sue spalle con le mani per non perdere l’equilibrio. I corvi. Non mi rendo conto di quello che sto facendo. Lo faccio automaticamente. Disperatamente. I tetti della città sono blu. L’aria è tersa. Mi oscillo frenetico. Mi sento allucinato. La porta si apre. Gli altri sono seduti. Non si voltano. Sono entrati a centinaia. Abbiamo perso la città. E’ la fine.
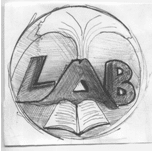
Nessun commento:
Posta un commento